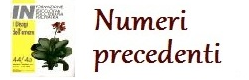Giuseppe Sacco
Istituto di Psicologia
Universita degli Studi di Siena
1. INTRODUZIONE
Ognuno sa cosa sia l’attenzione. E l’acquisizione da parte della mente, in una forma chiara e vivida di uno di quegli innumerevoli oggetti o serie di pensieri,
simultaneamente possibili. La focalizzazione, la concentrazione della
coscienza, costituiscono la sua essenza. Essa implica il ritrarsi da qualche cosa per rivolgersi efficacemente ad altro.) (W. James, 1890).
Abbiamo voluto iniziare con una citazione di W. James sia perche la
consideriamo una buona introduzione al nostro argomento, sia per attribuire un omaggio a un importante autore dello scorso secolo che viene pero spesso trascurato, nonostante i suoi lavori siano tuttora attuali e per molti versi
ancora stimolanti.
Come si puo vedere il concetto di «attenzione» e uno di quegli argomenti che da vecchia data sono stati affrontati con interesse dagli studiosi. E come tale ha subito numerose vicissitudini .
I filosofi e gli psicologi dello scorso secolo lo consideravano un concetto
centrale, ponendo spesso l’accento, come lo stesso James, sulla selettivita del processo di elaborazione.
Tuttavia, con la nascita del Comportamentismo nel XX secolo il concetto di
attenzione, come tutti gli altri concetti di tipo «mentalistico», e stato del tutto accantonato, finche non e ritornato alla ribalta negli anni ’50, in particolare col lavoro di Broadbent “Percezione e Comunicazione ” (1958).
Da allora si e cercato di ridefinire e circoscrivere il concetto di «attenzione».
Altre definizioni hanno posto l’accento sulla capacita di selezionare parte delle stimolazioni in arrivo, oppure, per esempio, come sinonimo di
concentrazione (Moray, 1969).
Tuttavia, nonostante le difficolta e la molteplicita delle definizioni esiste un accordo generalizzato su che cosa e che ci spinge a prestare attenzione ad alcuni stimoli piuttosto che ad altri: infatti, si sceglie di concentrarsi
prevalentemente sulle informazioni che al momento sono rilevanti per la nostra condotta e i nostri scopi attuali. Oppure su stimoli «catturanti»
l’attenzione, come per esempio, quelli che sono in conflitto con le nostre
aspettative, o con un carattere di novita, intensita, incongruita, etc. (Berlyne, 1960).
Fra le altre ipotesi interessanti proposte in tempi pill recenti abbiamo quella per cui l’attenzione costituisce l’insieme dei meccanismi e dei processi che la coscienza, intesa come un sottosistema che opera all’interno della mente per
«trattare» l’informazione, usa per controllare l’attivita mentale (Bagnara, 1984).
Negli studi pill recenti l’attenzione viene divisa in (Eysenk, Keane, 1995):
1) attenzione focalizzata e selettiva
2) attenzione distribuita o divisa.
La prima e quella che si studia attraverso la presentazione ai soggetti di due stimoli contemporanei, con la richiesta di elaborare e rispondere ad uno solo di essi. In questo modo si acquistano nozioni su come si selezionino alcuni
stimoli invece di altri; sulla natura dei processi selettivi e sugli stimoli che vengono trascurati.
Invece, l’attenzione distribuita si studia presentando almeno due stimoli in contemporanea, ma, questa volta con l’istruzione di elaborarli entrambi. In questo modo si acquistano nozioni sui limiti dei processi di elaborazione e sulle capacita attentive.
Uno dei grossi limiti della ricerca e costituito dal fatto che la quasi totalita degli studi prendono in considerazione l’attenzione agli “stimoli esterni”
trascurando cosi quasi del tutto l’attenzione agli “stimoli interni” (pensieri, immagini, emozioni, etc.).
In questo lavoro vogliamo invece proprio soffermarci sull’attenzione agli “stimoli interni” che in psicoterapia costituisce uno dei fenomeni di
importanza centrale.
II. L’IMPORTANZA DELL’ATTENZIONE IN PSICOTERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE
Abbiamo accennato alla scarsa considerazione attribuita dalla ricerca sull’attenzione agli «stimoli esterni». Al contrario, in ambito clinico
l’osservazione e lo studio dei processi attentivi del paziente orientati agli
«stimoli interni» diventa del tutto irrinunciabile.
Infatti, la conoscenza dei contenuti cognitivo-emotivo del paziente costituisce uno dei passaggi propedeutici fondamentali per una psicoterapia cognitivo-
comportamentale.
Per esempio, i pazienti con un symptom pattern di tipo fobico tenderanno a
selezionare pill probabilmente i loro processi attentivi verso l’elaborazione di contenuti interni di allarme e pericolo specialmente di tipo fisico; mentre i
pazienti con un symptom pattern di tipo depressivo tenderanno a dirigere la loro attenzione pill probabilmente verso contenuti interni di perdita,
separazione, esclusione, insuccesso, fallimento, etc.; oppure i pazienti con un symptom pattern di tipo «disturbi alimentari» tenderanno alla probabile
elaborazione selettiva di «stimoli interni» legati al cibo, alla fame, alla sazieta, alla linea, alle diete, all’aspetto fisico, etc.; mentre i pazienti con un symptom
pattern di tipo ossessivo orienteranno probabilmente la loro attenzione verso contenuti interni legati al dubbio, alla pulizia, alla sporcizia, alla ricerca
della perfezione, della verita assoluta, etc.
Il primo passo di strategia terapeutica in questo ambito consiste,
generalmente, proprio nell’aiutare il paziente a rendersi conto di queste sue modalita personali, attraverso l’esercitazione all’autosservazione in certe
osservazioni per lui critiche.
Solo successivamente sara possibile, in maniera graduale, aiutare il paziente a spostare e modulare i suoi processi attentivi verso altri contenuti o a
«processare» gli stessi contenuti secondo modalita alternative.
III. STRUMENTI DI VALUTAZIONE E DI AUTOVALUTAZIONE
Nell’ambito della strategia terapeutica di ristrutturazione e ri-orientamento dei processi attentivi assume un’importanza cruciale l’addestramento del
paziente all’autosservazione delle proprie modalita di elaborazione.
Uno strumento-tipo di autosservazione di cui ci si serve, fra i diversi a
disposizione, e costituito dalla famosa Scheda di Registrazione dei Pensieri Automatici (Vedi figura).
I pensieri automatici sono quei pensieri che vengono prodotti
spontaneamente e in modo automatico nelle varie situazioni della vita
quotidiana (Beck, 1976). Essi passano generalmente inosservati fintanto che i pazienti non vengono istruiti a fare attenzione ad essi. Attraverso
l’addestramento al ri-orientamento su di essi dell’attenzione ogni paziente (ma anche ogni persona comune) puo essere in grado di riconoscerli.
Fra le numerose caratteristiche dei pensieri automatici scoperti da Beck abbiamo la loro specificita rispetto alle situazioni, il loro stile abbreviato e telegrafico, la loro involontarieta e automaticita.
Il motivo fondamentale della loro importanza in clinica risiede nel fatto che
essi sono in stretta relazione (non di tipo causale) con le emozioni disturbanti del paziente (ansia, rabbia, tristezza, etc.), per cui la consapevolezza di essi
costituisce il primo passo per la loro eventuale modifica che, a sua volta puo beneficamente influenzare l’emozione disturbante.
Certamente, una psicoterapia non si esaurisce con la fase, seppur
fondamentale, dell’autosservazione. Infatti, una volta che il paziente ha
acquisito una buona capacita in tal senso si passa alla fase successiva in cui si esplorano le strutture di significato delle aree problematiche del paziente
(convinzioni e assunti di base, schemi, set o costellazioni cognitive). Anche in questa fase ci si puo servire di strumenti che aiutano il paziente a focalizzare la sua attenzione sulle sue modalita di elaborazione delle informazioni
interne, per esempio sulle immagini mentali prodotte spontaneamente o in alcune situazioni per lui problematiche. In tal caso, puo essere utile, per
esempio, l’uso del Q.M.I. edizione italiana (Sacco, 1994; in press) che aiuta a focalizzare l’attenzione del paziente sui suoi contenuti immaginativi e a
valutarli.
Altri strumenti di tipo self-report per la valutazione di schemi e costellazioni cognitive possono, per esempio, essere costituiti da batterie come il C.B.A.
(Cognitive-Behavioral-Assessment), le cui Scale permettono, tra l’altro,
l’indagine su nuclei cognitivo-emotivo-comportamentali di tipo clinico, come quello depressivo, fobico, ossessivo, etc. (Sanavio, et al., 1987).
Per l’esplorazione di eventuali problematiche di tipo “disturbi alimentari” possono essere utilizzati anche strumenti come l’E.A.T.- 40 (Cuzzolaro,
Petrilli, 1988) che fornisce delle indicazioni utili per comprendere l’esistenza o meno di specifiche modalita di direzione dei processi attentivi verso
contenuti relativi al cibo, alla fame, alla sazieta, alle diete, all’aspetto fisico, etc.
Registrazione giornaliera dei pensieri automatici
| Data | Situazione | Pensieriautomatici | Domandarelaprova | Terapiaalternativa | Re-attribuzione | De-catastrofizzare |
| Descrivi gli eventi concreti che conducono ad emozioni spiacevoli | 1Scrivi i pensieri automatici ,i sogni ad occhi aperti o i ricordi che precedono l’emozione2 Valuta la convinzione dei pensieri automatici0-100% | Qual’e la prova? | Qual’e un’opinione alternativa? | In quali modi sto personificando, ipergeneralizzando, usando un pensiero del tipo ‘tutto o niente’ oppure sto facendo confronti,o saltando alle conclusioni ? | Qual’e la cosa peggiore che potrebbe mai accadere?Anche se accadesse, cosa potrei fare? | |
| Emozioni | Risultato |
| Specifica se triste, arrabbiato ,ecc.2 Valuta il grado di emozione0-100% |
Rivaluta laconvinzione dei pensieri automatici0-100%Specifica e
valuta le successive emozioni 0-100% |
I) TERMINOLOGIAIV. METODI DI PSICOTERAPIA
Riteniamo opportuno, prima di entrare nel merito dell’argomento, di fornire alcune precisazioni sui termini usati in questo lavoro, in particolare sulle
parole “metodo”, “metodologia” e “tecnica”.
Per “metodo” si intende il criterio direttivo secondo cui si fa, si realizza o si compie qualcosa (Zanichelli, 1983). Sono usati come sinonimi: ordine,
procedimento, regola, norma, legge; mentre sono usati come contrari: confusione, disordine.
Per “metodologia” si intende: 1) parte della logica che ha per oggetto la
ricerca di regole o principi metodici che consentono di ordinare, sistemare, accrescere le nostre conoscenze; 2) dottrina filosofica che studia le tecniche di ricerca proprie di un determinato campo del sapere (Zanichelli, ibidem).
Per “tecnica” si intende: I) serie di norme che regolano il concreto
svolgimento di un’attivita manuale o intellettuale); 2) modo di lavorare, produrre, realizzare qualcosa.
Sono sinonimi: norma, regola, procedimento, metodologia, capacita, abilita, perizia, pratica.
Sono contrari: imperizia, inesperienza, incapacita.
Rispetto al nostro ambito di interesse specifico possiamo osservare come si parli pill frequentemente di “tecniche di terapia”, piuttosto che di “metodi”.
Anche se spesso questi due termini vengono usati come sinonimi (e abbiamo visto che in parte lo sono) noi preferiamo usare il termine “metodo” per una
serie di motivi che in parte accenniamo qui di seguito e in parte
svilupperemo nel prosieguo del nostro discorso. Ora possiamo sottolineare
come il termine “tecnica” possa risultare un po riduttivo o fuorviante perche nella terapia cognitivo-comportamentale (ma questo vale anche per altri
approcci) si mira a fornire al paziente dei principi metodici nuovi che gli
possono consentire di riordinare, sistematizzare, ristrutturare e accrescere la sua autoconoscenza, nell’ambito di sistemi parzialmente o totalmente nuovi di significato personale.
2) TEORIE CLASSICHE
Negli approcci terapeutici cognitivo-comportamentali classici (la RET di Ellis, la terapia cognitiva di Beck, etc.) quelle che vengono comunemente chiamate “tecniche” sono mirate principalmente alla modificazione delle idee irrazionali o delle convinzioni distorte sottese alle emozioni disturbanti (per es. Ellis,
1962; Beck, 1976; Sacco, 1989).
3) TEORIE SUCCESSIVE
Successivamente le “tecniche” in terapia cognitivo-comportamentale sono state riformulate come tattiche da utilizzare all’interno della strategia
terapeutica miranti a sviluppare una graduale autoconsapevolezza (Sacco, 1989).
4) APPROCCI PIU RECENTI
Recentemente e stato abbozzato un nuovo contesto teorico entro cui inserire le “tecniche” di terapia.
Tale modello, ancora in fase di elaborazione, e stato definito modello infodinamico (o “psicologia delle trasformazioni”) (Sacco, 1994; 1998, in press).
5) MODELLO INFODINAMICO (PsicoIogia deIIe trasformazioni)
I) Generalita
L infodinamica dei sistemi cognitivi (o psicologia delle trasformazioni) puo definirsi come quella disciplina la quale studia le leggi che regolano
l’organizzazione e la trasformazione dei processi di conoscenza dei sistemi
stessi, facendo riferimento, oltre alle leggi della psicologia e alle discipline ad essa collegate, per analogia, alle leggi della termodinamica (Sacco, ibidem.;
1998, in press).
L’infodinamica si occupa delle proprieta dei sistemi cognitivi, delle variazioni che si presentano quando il sistema passa da uno stato ad un altro e delle trasformazioni quanto-qualitative delle informazioni.
L’informazione costituisce l’unita di base delle strutture di significato che
complessivamente costituiscono il sistema di conoscenza individuale che si organizza attraverso l’elaborazione delle informazioni.
II) Proprieta
I sistemi cognitivi presentano 4 proprieta fondamentali con un postulato di base. Quest’ultimo asserisce l’ impossibilita di non elaborare informazione.
Le 4 proprieta sono:
1) eIaborativa (elaborazione di input esterni);
2) infoproduttiva (autoproduzione e selezione delle informazioni);
3) autoconsapevoIezza (qualita della coscienza);
4) autorganizzativa (capacita di organizzare le informazioni secondo strutture di significato uniche e irripetibili).
Tali proprieta sono fra loro interdipendenti e interagenti e sono collegate da relazioni sia strutturali che funzionali.
III) Variabili di stato
Analogamente a quanto accade per ogni altro sistema, anche per la
descrizione e la spiegazione dei processi che avvengono nei sistemi cognitivi e utile fissare un numero di parametri che possono definire univocamente lo
stato del sistema stesso. I parametri che definiscono e caratterizzano lo stato di un sistema vengono chiamati “variabili di stato”. Tali variabili sono:
1) entropia (grado di “disordine” del sistema)
2) veIocita (quantita di informazione elaborata nell’unita di tempo)
3) compIessita organizzativa (quantita e qualita di connessioni fra le informazioni)
4) coerenza organizzativa (livello di coerenza logica fra i significati costruiti)
5) dissipazione (quantita e qualita di informazione dispersa)
6) capacita (quantita complessiva di informazione elaborata)
7) profondita (quantita di elaborazione con cui e stata trattata un’informazione o una costellazione di informazioni).
IV) Stato di equilibrio
Uno stato di equilibrio e caratterizzato dal fatto che non si puo notare alcuna tendenza da parte del sistema a passare in uno stato diverso. Quando il
sistema passa da uno stato ad un altro si dice che esso attua una
trasformazione (vedi schema ).
Un sistema tende a modificare il suo stato di equilibrio quando avverte una discrepanza o una dissonanza all’interno delle sue strutture di significato.
Tali dissonanze possono produrre delle interferenze (rumore) nel sistema che, quando superano una certa soglia individuale (soglia di scompenso), possono a loro volta condurre a delle anomalie funzionali e vengono comunque
avvertite con una sensazione soggettiva di disagio e malessere da parte del sistema stesso.
Tale disagio puo condurre alla ricerca di un nuovo stato, di un nuovo livello di organizzazione del sistema, il cosiddetto “order through fluctuations”
(Prigogine, 1976).
| STATO A | «« | STATO B | «« | STATO C | |||||
|
Rottura equilibrio
Aumento entropia
Crescita rumore
Rottura integrazione I) Livello cognitivo: pensieri e immagini II) Livello emotivo: malessere III) Livellocomportamentale: ricercasoluzioni |
Acquisizione nuovo equilibrioDecremento rumore
Decremento rumore
Nuova integrazione(c-e-c)
Nuovo Stato Equilibrio Dinamico |
|||||||
| STRUTTURA DISSIPATIVA INIZIALE(SD1) | «« | STRUTTURA DISSIPATIVA INTERMEDIA(SD2) | «« | STRUTTURA DISSIPATIVA FINALE(SD3) | |||||
Si deve a I. Prigogine (1981,1982,1986) il concetto di sistemi o “strutture dissipative autorganizzate lontane dall’equilibrio”.
In termodinamica una “struttura dissipativa” e uno stato di ordine dinamico che puo essere mantenuto solo mediante un metabolismo, cioe mediante
una continua dissipazione di energia, dando origine a trasformazioni periodiche sincronizzate come avviene, per esempio, nel caso della
distribuzione dell’eccitazione nella rete e nelle cellule nervose, dove tali trasformazioni si diffondono ai vari livelli dell’intero sistema.
Tali strutture, per la loro azione di modulazione, richiedono una certa stabilita morfogenetica e sono, dunque, possibili dove e presente una cooperazione fra interazioni statiche e dinamiche, come nel caso degli organismi umani (Arcieri, 1988).
Per la formazione delle strutture dissipative sono necessarie una serie di condizioni di base:
I) e indispensabile trovarsi di fronte a “sistemi aperti” e percio lontani dall’equilibrio;
2) l’ordine nell’ambito delle trasformazioni presenti continuamente in un
sistema dinamico, funge da catalizzatore verso un livello di ordine superiore;
3) necessita periodica di energia proveniente dall’esterno pena il collasso del sistema stesso;
4) irreversibilita dei processi di costituzione e disfacimento dell’ordine
sistemico (impossibilita a ricostituire lo stato originario) (Arcieri, ibidem).
Queste condizioni di base, valide per i sistemi termici, sono valide anche per i sistemi biopsicologici e, in particolare, per i sistemi cognitivi.
In tal caso, va tenuto conto che non interessano solo i processi termici o energetici, ma anche i processi di elaborazione delle informazioni.
La relazione fra processi energetici e informazionali, in altre parole fra
cognizioni ed emozioni, in riferimento al concetto di «struttura dissipativa» e affrontata in altra sede (Sacco, 1998, in press).
Considerato cio abbiamo che i sistemi cognitivi, analogamente ai sistemi termodinamici, presentano le seguenti condizioni:
I) sono “sistemi aperti” lontani dall’equilibrio (Sacco, Sperini, 1997);
2) tutti i processi di ordinamento delle informazioni tendono ad assumere un andamento «autocatalitico”, nel senso che un certo ordine puo agire, a sua
volta, da catalizzatore verso un grado di ordine superiore;
3) necessita di elaborare informazioni pena il collasso del proprio ordine;
4) irreversibilita dei processi di organizzazione delle informazioni (impossibilita di ricostituire lo stato antecedente).
6) i metodi dl psicoterapia nel contesto teorico infodinamico
Secondo l’approccio teorico infodinamico, i metodi di psicoterapia sono principalmente finalizzati alla modulazione dei passaggi e delle trasformazioni da uno stato dissipativo dinamico a quello successivo.
In tal modo, i metodi di terapia sono mirati a “sviluppare una graduale
consapevolezza di se” attraverso il ri-orientamento e la ristrutturazione dei processi attentivi, rispetto a quelle informazioni sul se («stimoli interni») che non erano state elaborate in maniera adeguata per il sistema. Inoltre
possono costituire dei validi strumenti di gestione e fronteggiamento delle
situazioni di turbolenza create dall’incremento di entropia che si verifica negli
stati trasformativi dinamici.
E’ proprio in tal senso che e pill opportuno parlare di “metodi” piuttosto che di “tecniche”, in quanto si tratta dell’apprendimento di nuove modalita di
gestione delle fasi di passaggio e di trasformazione da uno stato dissipativo dinamico a quello successivo. Tali modalita si presentano come delle vere e proprie nuove configurazioni metodologiche che dovrebbero consentire al
paziente l’acquisizione di un nuovo metodo per affrontare le sue
problematiche esistenziali attraverso una diversa Weltanschaung.
Da cio si possono ricavare una serie di “concetti-guida”, nell’uso dei metodi terapeutici nel contesto infodinamico, che possiamo dividere in negativi e
positivi. Tra quelli negativi, che cioe possono considerarsi controindicazioni, quindi modalita da evitare, abbiamo (Sacco, 1992):
1) I’uso meccanico e ctecnicistico”;
2) I’uso passivo e spersonaIizzato;
3) I’uso avuIso daI contesto reIazionaIe;
4) I’uso secondo Ia “concezione farmacoIogica”.
In questi 4 punti strettamente collegati fra loro viene espressa l’inutilita, in alcuni casi la dannosita, di un uso stereotipato, spersonalizzato e senza
coinvolgimento partecipativo da parte del paziente (il cosiddetto “uso
farmacologico” dei metodi, presentati cioe analogamente ai farmaci, come un intervento “esterno” quasi deresponsabilizzato e meccanico).
Tra i “concetti-guida” positivi-propositivi dell’uso dei metodi terapeutici abbiamo invece:
1) I’uso coIIaborativo;
2) I’uso personaIizzato;
3) I’uso integrato neIIa reIazione;
4) I’uso secondo Ia concezione cumanistica”, voIto cioe aII’acquisizione da parte deI paziente di un valore metodologico aggiunto.
In questi quattro punti, anch’essi strettamente collegati fra loro, abbiamo la proposizione di una “filosofia” di impiego dei metodi psicoterapeutici.
Fondamentale risulta l’instaurazione di un “setting collaborativo” col paziente (Beck, 1985) che sara stimolato dal terapeuta attraverso il
coinvolgimento attivo all’apprendimento delle metodologie.
E’ evidente come in tutto cio risultano di importanza cruciale caratteristiche personali ormai classiche del terapeuta come: la competenza professionale; la credibilita; l’empatia; la sincerita e il vero interessamento ai problemi del paziente; l’accettazione del paziente; etc.
Tali caratteristiche funzionano da catalizzatori e facilitatori nella creazione del “setting collaborativo” che rimane una delle mete irrinunciabili del
processo terapeutico in generale e, in particolare, dell’efficacia dell’uso dei metodi stessi.
7) CLASSIFICAZIONE DEI METODI TERAPEUTICI
I) I ntroduzione
La classificazione e un’operazione che si compie in ogni disciplina scientifica con lo scopo di sistematizzare le informazioni disponibili in ogni settore.
Classificare, infatti, vuol dire ordinare per classi, tipologie, specie o categorie. Anche i metodi terapeutici sono stati variamente classificati, a seconda delle diverse esigenze di sistematizzazione.
Vedremo brevemente qui di seguito una classificazione classica e una pill recente con le diverse implicazioni a loro sostegno.
II) Classificazione classica
Gia nel 1979 Guidano e Liotti suddividevano le “tecniche” di terapia cognitivo-comportamentale in 2 gruppi principali: 1) tecniche di
autocontrollo; 2) tecniche di ristrutturazione cognitiva.
Pur essendo questa, come riconoscevano gli stessi autori, una divisione
principalmente didattica, avendo tutte le tecniche caratteristiche di entrambi i gruppi, le tecniche di autocontrollo presentano come bersaglio principale il
“sistema di rappresentazione” dell’individuo (dialogo interno, immagini);
mentre le tecniche di ristrutturazione cognitiva puntano prevalentemente al “sistema di convinzioni” individuale.
Secondo quest’ottica classificatoria fra le tecniche di autocontrollo erano incluse lo stress-inoculation e il self-instructional training; mentre fra le
tecniche di ristrutturazione sistematica trovavano collocazione la
ristrutturazione razionale sistematica e il problem-solving.
In un nostro lavoro successivo (Sacco, l989) avevamo incluso un sottogruppo particolare di tecniche di autocontrollo chiamato tecniche immaginative, che
erano prevalentemente mirate all’uso di immagini mentali.
Questo tipo di classificazione aveva senz’altro il pregio di essere utile per la sistematizzazione, in quanto semplice e fondamentalmente coerente col
modello proposto a quell’epoca dagli autori.
Tuttavia, il limite di tale classificazione e quello di essere tutta incentrata su elementi di sottosistemi in un modello “a blocchi”, trascurando o limitando la descrizione delle modalita di “processamento” delle informazioni, attraverso
l’impiego di unita prevalenti di codifica che risultano altamente individualizzate.
In altre parole, ci sembra pill utile avere a disposizione una classificazione
che tenga conto pill dei processi individuali di codifica (modalita di “trattare” le informazioni) piuttosto che del “blocco-bersaglio” su cui agisce il metodo. Tra l’altro, risulta evidentemente pill agevole identificare e distinguere una modalita, uno “stile di processamento” delle informazioni invece che
arrovellarsi su quale sottosistema quest’ultimo vada ad agire, essendo
un’impresa quasi disperata stabilire con precisione dove finiscono e dove iniziano i confini di un sottosistema.
III) Classificazione recente
Partendo da alcuni studi sui “codici” di elaborazione delle informazioni (teoria del “doppio codice”, Paivio, 1971; 1986; teoria del “triplo codice”,
Ahsen, 1977; 1984) abbiamo evidenziato altrove (Sacco, 1994) la presenza di
tre modalita elaborative principali:
1) il codice proposizionale che si serve di una modalita alfabetica o alfanumerica, con caratteristiche di elaborazione sequenziali;
2) il codice pittoriale (o immaginativo), che si serve di unita spaziali soggette all’elaborazione parallela;
3) di un codice psicosomatico che si serve delle modalita incrociate dei due codici precedenti collegandole e integrandole fra loro attraverso la
componente somatica. Da questa base abbiamo suddiviso i metodi di psicoterapia in tre gruppi:
1. metodi proposizionali
2. metodi pittoriali
3. metodi psicosomatici (o metodi olistici di autoesplorazione)
1. METODI PROPOSIZIONALI
I metodi proposizionali sono incentrati prevalentemente sull’uso del codice proposizionale che, in ambito clinico, corrisponde al dialogo interno.
I principali metodi proposizionali sono (Sacco, 1989):
I) stress-inoculation;
II) self-instructional training;
III) ristrutturazione razionale sistematica, etc.
Tali metodi tendono principalmente al ri-orientamento dell’attenzione sul dialogo interno del paziente che sara appunto addestrato a prestare
attenzione a cio che si dice mentalmente in quelle situazioni per lui critiche
e, successivamente, a prendere in considerazione l’esistenza di altri eventuali dialoghi interni (decentramento). Cosi, ad esempio, nel caso di un paziente
con problemi di ansia, invece di continuare a fissare la sua attenzione
soltanto su alcuni segnali provenienti dal proprio corpo (aumento battito cardiaco, sudorazione, tremore, etc.) egli la dirigera su cio che in quei
momenti gli verra in mente (pensieri, immagini); cio non soltanto lo “distrarra” dall’ansia ma lo aiutera anche ad ampliare la propria
autoconsapevolezza, oltre che ad affrontare la situazione critica con maggiori probabilita di miglioramento.
2. METODI PITTORIALI
l metodi pittoriali sono incentrati prevalentemente sull’uso del codice pittoriale (o immaginativo).
I principali metodi pittoriali sono (Beck, 1985, Sacco, 1989;1994):
I) turn-off;
II) ripetizione;
III) proiezione nel tempo;
IV) immagini simboliche;
V) facilitazione immagini indotte;
VI) sostituzione immagini;
VII) prova immaginativa-comportamentaIe
VIII) focalizzazione senso-motoria
IX) esposizione immaginativa prolungata etc.
Tali metodi tendono invece al ri-orientamento dell’attenzione sulle immagini mentali del paziente che sara addestrato, in questo caso, a centrare i suoi
processi attentivi alle proprie immagini nelle situazioni per lui problematiche e a modularle coordinandole col dialogo interno.
E’ evidente che i1 dialogo interno e le immagini mentali nella vita di tutti i giorni generalmente procedono in parallelo e percio e importante, quando possibile, addestrare il paziente ad utilizzare i metodi in maniera parallela.
3. METODI PSICOSOMATICI
Tali metodi costituiscono una particolare categoria che si serve dei due
codici proposizionale e pittorico combinati insieme, con la particolarita del
coinvolgimento diretto di organi, apparati e processi somatici (Sacco, 1994).
In tal caso i processi attentivi vengono canalizzati sulle capacita di
“autoguarigione” del corpo ponendo in risalto i processi riparativi e di recupero dell’organismo.
Questi metodi si servono, infatti, di un dialogo interno specifico, semistrutturato, che e affiancato da diversi tipi di immagini.
Una prima classe di immagini mentali e quella delle immagini metaforiche che rappresentano lo stato di malattia o le condizioni ad essa relative. Per es., un paziente con una colite ulcerosa puo visualizzare la sua malattia
come un vulcano che erutta roccia fusa e l’energia guaritrice come un temporale che porta torrenti di acqua fredda all’interno del vulcano,
spegnendo il fuoco e guarendo simbolicamente l’ulcera.
Un secondo tipo di immagini sono le immagini realistiche che costituiscono la visualizzazione di cio che accade effettivamente in una certa situazione. Per
es., un paziente con un processo infettivo in corso, puo visualizzare la scena dei suoi anticorpi che si preparano a muovere contro i batteri e li
distruggono.
Un altro tipo di immagini sono le immagini processuali che sono costituite dalla visualizzazione delle varie fasi della malattia del soggetto:
dall’insorgenza alla reazione dell’organismo allo stato patologico.
Infine, abbiamo le immagini della guarigione, che si incentrano sulla
visualizzazione dell’organo o dell’apparato ammalato che sono perfettamente guariti e funzionanti.
Anche se attualmente non si conoscono in maniera chiara i processi di “autoguarigione” dell’organismo e non si sono ancora ben comprese le
delicate e complesse interazioni “mente-corpo”, e possibile affermare che tali metodi possono rivelarsi, a volte, utili per sostenere e aiutare i pazienti ad
affrontare difficili situazioni di malattia in cui e necessario un forte supporto psicologico accanto a quello medico.
Tuttavia, al di la di queste situazioni, i metodi psicosomatici possono rivelarsi strumenti ancor pill utili e potenti se usati in parallelo con quelli
proposizionali e pittoriali. Infatti, per esempio, il ri-orientamento
dell’attenzione del paziente sul dialogo interno e sulle immagini risulta molto pill efficace quando sono coinvolti gli aspetti psicofisiologici, come di fatto
avviene nella vita di tutti i giorni, nella quale noi ci diciamo mentalmente delle cose (dialogo interno), esperiamo delle immagini (immagini mentali) mentre proviamo delle emozioni (attivazione psicofisiologica).
V. L’ATTENZIONE DELLO PSICOTERAPEUTA
Da quanto sopra detto si evince l’importanza cruciale, per lo psicoterapeuta di conoscere le proprie modalita di funzionamento cognitivo-emotivo e gli
schemi di relazione interpersonale.
Infatti un terapeuta che non conosce, almeno per gli aspetti pill rilevanti, cio che avviene «in casa propria» molto difficilmente potra essere di aiuto al
paziente a riconoscere cio che avviene nella sua «casa».
Senza contare per altro il grosso rischio di commettere errori tali da danneggiare in modo pericoloso il gia precario equilibrio mentale del paziente.
E’ per questo che parte fondamentale della formazione dei futuri terapeuti e, a nostro avviso, costituita da un’analisi didattica personale, da compiersi
sotto la guida di un trainer esperto, nella quale il trainee dovrebbe
apprendere a saper cogliere i propri pattern di elaborazione dell’informazione, (modulazione dei processi attentivi e percettivi personali; sistemi di
rappresentazione, etc.), ad approfondire l’autoconoscenza delle attitudini
relazionali e dei meccanismi di attivazione delle proprie modalita emozionali.
In generale, va aiutato il trainee ad autoesplorare i costrutti e le convinzioni
sul Se e sui rapporti interpersonali; le attribuzioni e le aspettative; gli schemi emotivi personali.
In particolare, risulta cruciale l’analisi cognitivo-comportamentale dei
pattern di attaccamento verso le figure significative; dei pattern di lotta, fuga ed evitamento; dei pattern di espressione della paura, della rabbia, della
tristezza e della gioia, e degli schemi interpersonali in generale.
L’atteggiamento affettivo-relazionale del terapeuta, cioe la capacita di
prestare attenzione e gestire i suoi atteggiamenti emotivi nella relazione
terapeutica, svolge un ruolo centrale nell’analisi e revisione delle convinzioni e delle aspettative del paziente sui rapporti interpersonali .
E’ fondamentale, per esempio, in un paziente con convinzioni di
autoindegnita personale, non rinforzare i suoi atteggiamenti negativi con atteggiamenti svalutativi e rifiutanti; oppure, in una paziente con
un’aspettativa del giudizio negativo altrui evitare atteggiamenti esaminatori e giudicanti.
Ma per rendere possibile quanto sopra accennato e necessario che il futuro terapeuta sperimenti direttamente su se stesso, sulle proprie modalita di
funzionamento, con le proprie problematiche di vita, la metodologia terapeutica che si appresta ad apprendere, a cominciare proprio
dall’esperienza di essere lui stesso un paziente beneficiario della psicoterapia.
E’ in questo modo che l’allievo puo esperire direttamente gli aspetti
qualificanti del vissuto dell’«essere-paziente» in relazione alla figura del terapeuta, provando in prima persona eventuali emozioni di paura,
vergogna, rabbia, abbandono, etc. che caratterizzano la relazione terapeutica, come del resto tutte le relazioni umane.
Attraverso questa sperimentazione personale l’allievo potra essere stimolato all’autoscoperta di nuovi aspetti di se che gli erano sconosciuti e avra altresi l’opportunita di unire e comporre l’esperienza didattica di tipo teorico-
dichiarativo con quella pratico-esperenziale, vera chiave di volta del pieno compimento di un percorso formativo completo che unisca e amalgami fra
loro tutti gli elementi costitutivi classici della formazione: sapere- saper fare- saper essere.
BIBLIOGRAFIA
Ahsen A. (1977): Eidetics: an overview. Journal of Mental Imagery, 1, 5-38. Ahsen A. (1984): The triple code model for imagery and psychophysiology.
Journal of Mental Imagery, 8, 1 -41.
Arcieri G. ( 1988): Introduzione alla medicina cibernetica e quantistica. IPSA Ed., Milano.
Beck A.T. (1976): Cognitive therapy and the emotional disorders.
International Universities Press, N.Y. (Tr. it. : Principi di terapia cognitiva.
Astrolabio, Roma, 1984).
Beck A.T., Emery G. (1985): Anxiety disorders and phobias. Basic Books, Inc., Pubblishers, N.Y. (Tr. it.: L’ ansia e le fobie. Astrolabio, Roma, 1988).
Bagnara S. (1984): L’ attenzione. Il Mulino, Bologna.
Berlyne D.E. (1960): Conflict arousal and curiosity London: McGraw-Hill. Broadbent D.E. (1958): Perception and communication. Oxford: Pergamon.
Cuzzolaro M., Petrilli A. (1988): Validazione della versione italiana dell’EAT-
40. Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Vol. 55, pp. 209-17.
Eysenck M. W., Keane M. T. (1990): Cognitive psychology. A students Handbook. Lawrence Elrbaum Associates Ltd., Publishers.
Ellis A. (1962): Reason and emotion in psychotherapy Lyle Stuart, New York.
Guidano V., Liotti G. (1979): Elementi di psicoterapia comportamentale.
Bulzoni, Roma.
James W. ( 1890): Principles of psychology. New York: Holt.
Moray N. (1969): Attention: selective processes in vision and hearing. London: Hutchinson.
Paivio A. (1971): Imagery and verbal processess. N.Y.: Holt.
Paivio A. (1986): Mental representation. Oxford University Press, N.Y.
Prigogine I. (1976): 0rder through fluctuations: self-organization and social systems. Jontsch, Waddigton.
Prigogine I. ( 1981 ): La nuova alleanza. Einaudi, Torino.
Prigogine I. (1982): Le strutture dissipative. Sansoni, Firenze. Prigogine I. (1986): Dall’essere al divenire. Einaudi, Torino.
Sacco G. (1989): Tecniche della terapia cognitivo-comportamentale. Melusina, Roma.
Sacco G., Isola L. (1992): La relazione terapeutica nelle terapie cognitive.
Melusina, Roma.
Sacco G. (1994): I giochi della mente. Melusina, Roma.
Sacco G., Sperini M. (1997): Introduzione alla filosofia dei sistemi. Edizioni Andromeda, Bologna.
Sacco G. (1998, in press): La crisalide e la farfalla.
Sanavio E., Bertolotti G., Michielin P., Vidotto G., Zotti A.M. (1986): CBA-2.0: Scale Primarie. Manuale. Organizzazioni Speciali, Firenze.
Zanichelli (1983): Dizionario della lingua italiana.


 Intervista ad Antonio Ferrara *
Intervista ad Antonio Ferrara * di Oliviero Rossi *
di Oliviero Rossi *
 Ovvero il terapeuta in stato di Flusso/Riflessività.
Ovvero il terapeuta in stato di Flusso/Riflessività. Intervista raccolta da Antonio Ferrara**
Intervista raccolta da Antonio Ferrara**