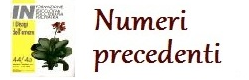Le “cure disperate” in psichiatria
di Luigi Attenasio
Articolo tratto da “Cos’è che Cura. La cura in ambito medico,psicologico, psicoterapeutico e psichiatrico”. Quaderni di IN Psicologia, Psicoterapia, Psichiatria, supplemento di Nuove Arti Terapie, Roma. Editore Nuova Associazione per le Arti Terapie, 2014.
Io ti salverò da ogni malinconia,
perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te… io sì, che avrò cura di te.
Franco Battiato
Cura è una parola molto antica
Le parole molto antiche sono come le case abitate dai fantasmi. Il nuovo padrone può sforzarsi quanto vuole di non salire in soffitta (o di non scendere in cantina), di non aprire quella porta e di tenere sempre accesa la luce di notte. I sussurri di chi è venuto
prima passano i muri; le ombre non c’è lampada che le disperda… O come le scatole degli illusionisti. Aperte, sembrano vuote. Le richiudi, le riapri, e ti salta fuori la colomba bianca con il suo caratteristico frullo d’ali (Gardini, 2014),e ha vari significati. Uno è pensiero fisso, angoscia, ossessione. Così lo usa Leopardi ne La sera del dì di festa: «e non ti morde / cura nessuna». Un altro possibile è amministrare, farsi carico, gestire. È nel concetto latino di cura. Esiste anche un significato più strettamente medico di terapia, trattamento o guarigione, quello che per Galeno e Celso è sanatio o curatio. Cura è anche il sentimento di preoccupazione, di ansia ma anche di sollecitudine, protezione e attenzione nei confronti di chi soffre o di chi è più debole, come ad esempio la cura dei neonati, che indica un coinvolgimento del tutto positivo di chi “cura”. Il ter- mine può rinviare così a guarire ma anche a prendersi cura, quello che in inglese è distinto in to cure e to care. Questa distinzione è importante: il primo significato, quello di ammi- nistrare, è assolutamente prevalente fino all’inizio dell’Ottocento. Ambroise Paré nel XVI secolo affermava «Je l’ay pansait, Dieu l’a guerit» (Io l’ho curato, Dio l’ha guarito).
La guarigione è il risultato dell’azione della natura o della provvidenza divina, non dell’azione del medico, che si limita per l’appunto a curare, a partecipare al decorso della malattia, ad ammini- strarlo, cercando di agire su di esso, insieme al suo paziente, utilizzando tutte le risorse della sua arte per attenuarne le conseguenze e per indirizzarlo verso un esito positivo. Il medico curante è il medi- co che si prende cura dei suoi malati, li consiglia, li guida, li amministra con sollecitudine. Di più, i medici che promettono guarigioni sono spesso considerati dei ciarlatani, se non dei furfanti che profittano della credulità della gente per far credere a soluzioni miracolose (Fantini, 1995).
A partire dall’inizio dell’Ottocento, invece, la medicina emergente, divenuta “scien- tifica”, determina la trasformazione del significato: curare è solo sinonimo di tratta- mento o guarigione. Questo mutamento è dovuto a una rivoluzione teorica causata dall’introduzione in medicina del concetto di causa specifica. La conseguenza è che il malato perde importanza e il medico si rivolge più alla tecnica, al laboratorio, alla terapia, alla farmacologia… La medicina diviene medicina dei numeri da opporre alla medicina delle qualità. Comincerà così quella rivoluzione che, attraverso la te- oria cellulare, il primato del laboratorio e della microbiologia, della genetica e della biologia molecolare, porterà fino ai nostri giorni alla medicina predittiva con un’idea trasformata anche della malattia, meno drammatica e più soft, più ovattata di quella conosciuta nell’Ottocento, con un decorso meno rapido, più discreto, più attenuato dalle cure o forse anche perché ne è protagonista una patologia diversa che nel pas- sato, il cancro ad esempio. Sono mutate le manifestazioni esteriori della malattia con una trasformazione sul versante soggettivo della sofferenza, ma sono mutate anche le stesse definizioni di malattia, sempre più collegate allo sviluppo della tecnologia bio- medica. La medicina predittiva potrebbe predire con buona approssimazione le pro- babilità di sviluppo di una data affezione patologica. In questo senso aver conosciuto e ricostruito la filiera del genoma umano è la massima conquista di tale periodo e consente di affermare con un certo anticipo quali sono le probabilità di sviluppare una data malattia. Ma, per chiarire subito, tale scoperta non prevede anche la solu- zione efficace del problema. Si può predire ma può essere inutile se non è stata allo stesso tempo trovata la terapia, e non è probabile che essa venga scoperta a breve.
Si è perduto anche un altro significato del termine “curare”, cioè il concetto di “cre- scere”, di scambio comunicativo nel senso di una trasformazione evolutiva (le cure materne…) contrariamente a quello, troppo semplicistico di stampo ed eredità posi- tivistici, di ricomposizione della situazione originaria quo ante. Non è forse questo un modo di ridurre il ventaglio delle possibilità che il prendersi cura propone e offre in opposizione a tutto ciò che altrove abbiamo chiamato risposta preformata?
Approfondiamo che cosa sia “cura” dando uno sguardo al dizionario Treccani. Il tutto si complica. Riportiamo le definizioni:
1a. Interessamento solerte e premuroso per un oggetto, che impegna sia il nostro animo sia la nostra attività. 1 b. Riguardo, attenzione. 1 c. Impegno, zelo, diligenza. 1 d. L’attività in cui si è direttamente impegnati. 1 e. Oggetto costante (costituito da persone o cose) dei propri pensieri, delle proprie attenzioni, del proprio attaccamento.
2a. Il complesso dei mezzi terapeutici e delle prescrizioni mediche che hanno il fine di guarire una malattia (sinon. di terapia, ma con significato e uso più ampi). 2 b. Uso continuato di un rimedio. 2 c. L’opera prestata dal medico per guarire un ammalato.
3a. Attività di assistenza, sorveglianza e simili, nelle varie forme con cui essa viene esercitata da un curatore. 3 b. In diritto romano, istituto di diritto pubblico che consisteva nell’attri- buire a magistrati straordinari compiti particolari che o non rientravano nella competenza delle magistrature ordinarie o richiedevano un’attività specializzata e intensa. 4. In senso spirituale, cura d’anime, il governo delle coscienze, e in particolare il ministero che esercita il sacerdote nella sua parrocchia; di qui, cura, con uso assol., l’insieme dei fedeli affidati al parroco o “curato”, e la casa parrocchiale con la chiesa 5. Letter. pensiero molesto, affanno, preoccupazione (conforme al sign. latino del termine); per lo più al plur.
Sono dunque cinque i campi di significato: di tipo cognitivo e comportamentale, più prettamente medico, a carattere sociogiuridico, spirituale; l’ultimo, con riferimento al linguaggio letterario, è di genere passionale.
A questo punto il mondo di significati della cura si può senza troppo sforzo farlo coincidere con il mondo in tutto e per tutto: la cura riguarda il pensiero come la passione, il lavoro come le relazioni, la scienza, il diritto, la religione, in pratica la cura dice quasi tutto il reale. Si può dire, in senso generalizzato, che la cura è un atteggiamento, una tensione interiore che in qualche modo modifica la qualità e aggiunge valore all’attività che svolgiamo, attività (spi- rituale o pratica che sia) alla quale rimane comunque strettamente legata. Se confrontiamo la prima e la quinta definizione, la cura è «qualcosa che interessa, attrae, richiama la nostra attenzione, il nostro impegno, tira fuori il meglio di noi stessi, eppure contemporaneamente angoscia, cattura l’animo fino a divenire molesta, lotta dentro di noi per diventare protagoni- sta della nostra vita, diventa pervasiva come un morbo» (Marinelli, 2002, ).
Nella cura ci si impegna, ci si lascia coinvolgere, ci mettiamo in gioco, rischiamo. Mi sembra opportuno ricordare le parole di Pietro Ingrao, ospite prestigioso nel con- vegno “L’obbligo di prendersi cura” (Roma, 2000), rivolte con l’umiltà propria dei grandi agli operatori della salute mentale:
Qui è la domanda a cui non so rispondere: che cosa è la salute e che cosa è la malattia? Fin dove quella malattia è malattia o è ricerca disperata di salute, illusione di salute? Che cosa è la cura e fin dove è aiuto e nobile fratellanza e fin dove invece è coercizione? Da ciò il rispetto verso quelli di loro che ogni giorno cercano risposte a domande così aspre e un criterio per muovere in quella tensione dell’individualità che in qualche modo confligge con la norma, e quale norma e fatta da chi. Io non sono proprio capace di dare – non dico aiuto – ma qualche consiglio per questo aspro compito, il problema inaudito che si trovano ad affrontare ogni giorno, non so con quante speranze e con quante carte in mano.
Il semiologo Paolo Fabbri (1995) evidenzia che «le parole sicurezza e curiosità hanno in comune la radice cura. Si-curezza deriva da sine-cura, cioè senza preoccu- pazioni, senza problemi: uno stato da raggiungere in cui si è certi. Chi è sicuro è colui che rinuncia alla cura. Da ciò quindi incuria, non-curanza».
Per Fabbri il concetto di salute deriva da salvus, “colui che si salva”, ed è stato da sempre interpretato come una salvezza dalle perturbazioni esterne a difesa della propria integrità. L’uomo ha sempre teso all’assenza di sollecitazioni, all’astenia e anche a una certa depressione, insomma all’incuriosità, lontano dalle cure. Cur- iosità, chi è curioso s’impegna nella cura. Fabbri fa una ricognizione nella storia, specie recente, del nostro pensiero, sottolineando quanto questo sentimento abbia dato fastidio, sia stato bollato come frivolo e sciocco. Ma è anche vero che la scien- za e la coscienza moderne si sono costituite a partire dalla curiosità. La curiosità è costitutiva del soggetto, scrive Fabbri, «coscienza moderna in quanto coscienza di sé per l’altro, perché nella curiosità c’è la cura di qualcosa oltre che la cura di se stessi» (ivi, p. ).
Fabbri osserva che un nuovo significato di salute potrebbe riferirsi a un qualcosa di non chiuso ma aperto cioè che mira a una certa indeterminazione, il che vuol dire che l’identità è un processo aperto di soggettività alla condizione, però, che questa sia “curiosa” cioè s’impegni nella cura. Ma la curiosità sperimenta e l’es-perienza è, nell’etimo, equivalente al pericolo, cioè comporta sempre un rischio.
Se facciamo riferimento alla nostra esperienza, i due aspetti del problema apparente- mente in antitesi convivono indissolubilmente nella cura e ne costituiscono la spinta vitale ma anche il pericolo più grande.
È per il suo carattere di convivenza con l’imprevisto e con l’irrazionale che la cura è un tipo di sapere che si costruisce strada facendo, una procedura di cui non può esistere manuale d’istruzione teorico già pronto, ma che nasce nel continuo rapporto tra stimolo e risposta, errore e correzione, ascolto e intervento.
In sostanza, le parole chiave riscontrate nelle strategie di gestione della cura che rinvia alla complessità, all’imprevisto, all’irrazionale, al disordine, si possono riassumere in ascolto, rispetto, intuizione, sagacità, umiltà (saper includere l’insicurezza nel pro- prio orizzonte), capacità di vivere il reale come un necessario intreccio di disordine e ordine, razionale e irrazionale, prendere parte a questa complessità senza tentare di ridurla, semplificarla, ossificarla, ma lasciandosi guidare, affinare e seguire il proprio fiuto.
Tutto ciò ha punti di contatto con quello che abbiamo chiamato deistituzionaliz- zazione. Essa ha trasformato il suo statuto di razionalità facendo sì che l’azione te- rapeutica non fosse più procedura codificata, lineare, unica ma «si arricchisse e si articolasse in una varietà di risorse, attori, strategie complesse ma anche appartenenti alla banalità del quotidiano ed elementari per cui ogni atto, ogni rapporto nella vita delle persone, ogni relazione positiva può essere terapeutica» (De Leonardis, 1990, ).
Proprio per questo l’azione è realmente terapeutica, infatti «cura in quanto entra nel rischio della vita, contagia, cioè crea, suscita, sorregge, in un gioco di complicità, la capacità di rischio dell’altro, la sua autonomia, le sue possibilità di convivere con le incertezze della vita e di prendervi delle decisioni» (ivi, ).
Anche per il farmaco, come per il termine “cura”, è necessario abbandonare le certez- ze di un significato univoco che di solito lo riferisce soltanto a sostanze dotate di virtù “terapeutiche”. Ha di fatto perduto, come ricorda Franca Ongaro Basaglia (1979) la doppia connotazione, positiva e negativa, implicita nel termine greco da cui deriva:
Il greco farmakon, così come il latino medicamentum, conteneva in sé sia il significato positivo di rimedio, medicina, filtro magico, sia quello negativo di veleno, tossico; doppio significato ancora presente nel termine inglese drug riferibile sia ai farmaci sia alle droghe vere e pro- prie, cioè a sostanze naturali o composti chimici con effetti stupefacenti. Il farmaco è inteso, dunque, di per se stesso come un veleno, così come il veleno può essere originariamente un farmaco. La connotazione positiva o negativa implicita nel prodotto risulta direttamente le- gata all’uso, alla finalità, al contesto in cui lo si utilizza, alla quantità e alla qualità rapportata
all’individuo, alla sofferenza specifica del suo corpo; al margine di possibilità lasciatogli di ap- propriarsi di questo corpo attraverso l’aiuto della sostanza estranea o alla misura in cui viene da essa determinato e condizionato (farmaco/droga).
L’autrice suggerisce di tener presente che l’uso di ogni strumento tecnico è «una oc- casione e momento di consapevolezza e di lotta contro tutto ciò che ci gioca [ok?] proponendo costantemente l’accessibilità a una salute, un benessere e una felicità che hanno i colori e la tenuità di una oleografia in cui si vorrebbe immergersi, ma che sono il richiamo di una Circe pronta a tramutarci in porci, asserviti al suo dominio» (ibid.).
CURE DISPERATE
Lo scopo principale della scienza
non è aprire la porta alla saggezza infinita ma porre un limite all’errore infinito.
Bertolt Brecht
Alla fine del XIX secolo e nei primi decenni del XX poche erano le speranze per i pazienti psichiatrici gravemente malati, ricoverati negli istituti.
I folli “incurabili” avevano compiuto ben pochi progressi dal giorno in cui Pinel in Francia (1793) e Rush negli Stati Uniti (1812) avevano per la prima volta richiesto trattamenti umani per i malati di mente2. I pazienti venivano picchiati e subivano maltrattamenti brutali. Venivano tenuti in celle scure, umide e affollate e spesso co-stretti in camicie di forza per settimane di seguito. Dalle catene reali erano passati ad altre catene, quelle della scienza psichiatrica che stava costruendo un suo statuto mentre nel contempo nascevano i manicomi con le conseguenti pratiche repressive. L’idea dominante dell’epoca era che, se la follia è causata da un evento traumatico, un trauma di uguale o di maggiore intensità può servire a ristabilire l’equilibrio. Come dire che, se il cervello è malato, forse prendendolo a calci si rimette a posto! Diretta conseguenza sono le cure di shock inventate nel Novecento.
Il primo “scuotimento” fu quello indotto dalla malaria. Si inoculava il plasmodio del- la malaria e si induceva artificialmente la malattia e si aspettavano le crisi febbrili che si esprimevano con evidenti tremori. Non si basa su alcun presupposto scientifico, ri- prende i principi terapeutici del XVIII secolo, “chiodo scaccia chiodo”, e soprattutto poggia sul principio che la malattia sia l’invasione di un agente esterno. La cura era espellerlo dal corpo. In auge fino agli anni cinquanta del Novecento, per questa sco- perta venne assegnato nel 1927 il Nobel per la medicina a Julius Wagner von Jauregg. La grande rivoluzione nella cura della malattia mentale sembrò definitivamente giun- ta negli anni trenta con quattro terapie somatiche radicali: tre basate sull’induzione di uno shock, e una di tipo chirurgico. Le teorie che “spiegavano” il loro meccanismo d’azione si rivelarono erronee e così vaghe da non poter essere prese in considera- zione. Tuttavia queste terapie appena introdotte furono salutate con entusiasmo dai medici e dall’opinione pubblica e furono ampiamente impiegate negli anni quaranta e in parte dei cinquanta.
La cura insulinica
La prima descrizione dell’insulinoterapia è di Manfred Joshua Sakel, medico vienne- se. Strano e introverso, Sakel era ossessionato dal bisogno di affermare la sua priorità non solo per l’insulinoterapia, mai contestata, ma di tutte le terapie di shock. Nella prima pubblicazione (1930) la descriveva come una cura per la tossicomania. Ri- portava la guarigione di 15 pazienti morfinomani senza un solo insuccesso, ma non indicava ciò che egli intendesse per guarigione e non vi era un follow-up dei pazienti. In questo lavoro iniziale Sakel indusse un coma profondo in un paziente, ancora una volta accidentalmente, iniettandogli una dose elevata di insulina. Le condizioni mentali del paziente, psicotico oltre che tossicomane, sembrarono migliorare dopo l’uscita dal coma.
L’epilessia farmacologica
Nello stesso periodo Joseph Ladislas von Meduna iniziò con lo shock metrazolico. Dapprima su animali, Meduna indusse convulsioni con diverse sostanze chimiche, utilizzando infine la canfora, estratto da un particolare cespuglio di lauro. Iniettò la canfora a pazienti schizofrenici; in seguito usò il metrazolo, un preparato sin- tetico (cardiazolo). Il primo paziente fu uno schizofrenico catatonico, alimentato con sonda, che da quattro anni non si muoveva quasi più. A tutti i bisogni organici provvedeva il personale ospedaliero. Dopo la quinta convulsione, il paziente scese dal letto, si vestì e iniziò a interessarsi a tutto. Meduna “curò” 5 malati e pensò di aver scoperto una nuova terapia. In poco l’uso del metrazolo si diffuse negli Stati Uniti e dal 1940 quasi tutte le più importanti istituzioni psichiatriche lo usarono come cura di elezione.
L’elettroshock
Il terzo trattamento convulsivo, l’elettroshock, fu ideato da Ugo Cerletti, con un gio- vane collaboratore, Lucio Bini. Come Meduna, anche Cerletti lavorava con pazienti epilettici e si convinse che si producesse una “sostanza vitalizzante” in risposta allo stress di una convulsione. In seguito, Cerletti indicò questa ipotetica sostanza con il termine “acroamine” e provò a produrla con scosse elettriche inflitte ad animali con un apparecchio realizzato da Bini. Si inducevano convulsioni senza difficoltà, ma molti animali morivano. Fu Bini a comprendere che morivano non per le convulsio- ni ma per il passaggio dell’elettricità attraverso il cuore. Quando gli elettrodi furono trasferiti dalla bocca e dall’ano ai lati del capo, nessun animale morì. In Cerletti l’idea di usare l’ESK era nata osservando che nel mattatoio di Roma i maiali con- dotti al macello erano “anestetizzati” con una scarica elettrica. Pensò di riprodurre la “cura” per i maiali sui malati (!) e nell’aprile 1938 la sperimentò su una persona. Per Cerletti non la convulsione ma le “acroamine”, formatesi nell’organismo in risposta allo stress, davano il miglioramento. In effetti, egli voleva eliminare le convulsioni, ritenute sgradevoli. L’ESK veniva considerato più sicuro e facile da somministrare, meno costoso e “più gradevole” del metrazolo. La stampa ebbe un ruolo importan- te nel diffondere queste terapie. Articoli entusiastici sulla cura apparvero su riviste molto diffuse (“Time”, “Newsweek”). Non si diceva che le convulsioni erano spesso violente e provocavano fratture, soprattutto di femore, braccio, scapola, colonna, mandibola e acetabolo, più che con il metrazolo. In parte per questo motivo, ma soprattutto perché più facile da somministrare, l’elettroshock sostituì rapidamente il metrazolo e a tutt’oggi continua a essere usato3.
La psicochirurgia
Nel 1935, in un ospedale di Lisbona, un neurochirurgo praticò due fori nel cranio di un malato di mente e iniettò alcool nei lobi frontali. In seguito la tecnica venne modificata: anziché distruggere le cellule nervose con l’alcool, il chirurgo introdus- se nel cervello uno strumento appositamente realizzato e recise e distrusse le fibre nervose. A Egas Moniz, per tale “invenzione”, nel 1949 venne dato il Nobel per la medicina. La teoria della “leucotomia prefrontale” era basata sull’idea dell’origine somatica della malattia mentale. I lobi frontali erano la zona responsabile dell’at- tività psichica. Una cura efficace, per Moniz, era la distruzione dei circuiti nervosi dove erano stati depositati i “pensieri fissi” patologici che interferivano con la vita mentale normale. In breve la psicochirurgia fu usata in tutto il mondo come tera- pia per le più svariate “malattie dell’anima” (tossicomania, criminalità, alcoolismo, insufficienza mentale).
Un danno ai lobi frontali induceva alterazioni considerevoli. Il neurochirurgo ame- ricano Percival Bailey rivelò: «Io esito prima di asportare un lobo frontale. Questo intervento dà alterazioni più o meno profonde del carattere e dà difetti nel giudizio. In una lavandaia questi effetti possono avere scarsa importanza, ma quando il pazien- te è un professionista impegnato, che deve prendere decisioni che riguardano molte persone, queste conseguenze possono essere disastrose» . Nel 1948, al I Congresso di psicochirurgia di Lisbona, Diego Furtado, un neurologo, sostenne: «Non possiamo dubitare che l’intervento ideato dal genio di Moniz risolva determinate condizioni di tensione ansiosa, determini la scomparsa di idee ossessive, renda meno intensa l’attività delirante e riduca gli errori psicosensoriali. Il problema è però stabilire quale sia il prezzo pagato per il miglioramento ottenuto, cioè quali siano le modificazioni definitive della personalità inflitte dalla mutilazione frontale» .
I sintomi post intervento erano: impoverimento della personalità, apatia, acinesia, atteggiamento catatonico, mutismo, negativismo, alterato orientamento spazio-tem- porale, infantilismo, alterazione del senso della fame, perdita del giudizio critico e di ogni rapporto con la realtà: una morte intellettiva e affettiva. Nonostante queste certe conseguenze, la lobotomia si diffuse perché consentiva un grande risparmio economico alle istituzioni psichiatriche sovraffollate e carenti di personale: i pazienti lobotomizzati, dopo breve degenza, venivano riconsegnati alle loro famiglie.
Le lobotomie aumentarono molto nei cinque anni successivi alla Seconda guerra mondiale: quando l’ESK era inefficace, essa era accettata in modo acritico da quasi tutti gli psichiatri. I neurochirurghi, su fondamenti scientifici scarsi o totalmente assenti, si sbizzarrirono, moltiplicando le tecniche psicochirurgiche. Nel 1947, John Fulton scrisse a Walter Freeman chiedendogli: «Cosa sono queste cose terribili che ho sentito sulle lobotomie che stai facendo nel tuo studio con uno stiletto per il ghiaccio? In California e in Minnesota ne ho sentito parlare. Perché non usi un fucile? Sarebbe più rapido!». Freeman, insoddisfatto dei risultati della lobotomia prefrontale, decise di utilizzare la transorbitaria, che Fiamberti aveva realizzato nel 1937. Accedeva ai lobi frontali inserendo un leucotomo (quasi uno stiletto per rom- pere il ghiaccio, fatto apposta per questi interventi) nella parte ossea dell’orbita dietro al globo oculare; non iniettava alcool o formalina per distruggere le cellule e le fibre nervose, come Fiamberti, ma le recideva. Temeva che qualsiasi fluido potesse diffondersi più del voluto. Usava l’ESK solo come anestetico. Operava rapidamente con il paziente ancora privo di coscienza dopo lo shock e sosteneva, senza nessu- na evidenza, che questo ne aumentava l’efficacia. Nel periodo di massimo fulgore (1949-1952) si fecero ogni anno negli Stati Uniti circa 5.000 interventi. Uno su tre era una lobotomia transorbitaria. Gli psicofarmaci sostituirono questa “pratica terapeutica”.
Altre ipotesi e “cure disperate”
La teoria dell’instabilità mentale. Era noto che gli squilibri ormonali influenzava- no le condizioni psichiche e l’umore e che la depressione e l’irritabilità potevano originare da ipo/iperattività di tiroide o surrenali. Tiroidectomie, ovariectomie, interventi di castrazione maschile e asportazione totale o parziale di altre ghian- dole endocrine di malati mentali furono decine di migliaia nel mondo negli anni successivi al 1920.
La teoria dell’attivazione respiratoria e metabolica. Curare con la “stimolazione psi- chica” indotta da un’attivazione respiratoria o metabolica è stato provato negli anni venti del Novecento. Arthur Loevenhart, docente all’Università del Wisconsin, iniettò piccole dosi di cianuro di sodio. Ci furono miglioramenti in schizofrenici. Nel 1929 fece respirare loro una miscela gassosa con il 30% di CO2 invece dello 0,03% presente nell’atmosfera. L’elevata concentrazione di CO2 eccitava il sistema nervoso.
La teoria dell’inerzia mentale. Per Walter Freeman gli schizo- frenici soffrivano di “inerzia mentale” a causa di un metabolismo cerebrale rallenta- to, una carenza di ossigeno. Freeman ipotizzava che un surplus di ossigeno giovasse agli schizofrenici, e descriveva risultati “incoraggianti” dopo averli posti in camere iperbariche al Navy Laboratory [USA]. Il possibile rapporto fra metabolismo cerebrale e patologia mentale ispirò nuove ricerche, e si pubblicò molto sul consu- mo di ossigeno nel cervello di schizofrenici e “normali”. Nel 1935 Robert Carroll, direttore sanitario dell’Highland Hospital di Asheville nel North Carolina, iniettò nel liquido cerebrospinale di schizofrenici sangue prelevato da cavalli. Aveva letto che i leucociti erano in numero minore negli schizofrenici quando i sintomi erano più gravi e in numero maggiore in fase di miglioramento. Si induceva la leucocitosi con puntura lombare, 25 cc di “siero di cavallo inattivato” nel liquor del paziente, al quale veniva prima estratta una pari quantità di liquido. Questo veniva ripetuto più volte per indurre una “meningite asettica” con leggera febbre a cui, secondo Carroll, si accompagnavano lievi rachialgie, cefalee e qualche accesso di vomito per alcuni giorni. Dopo le iniezioni, egli riferiva che i pazienti diventavano lucidi, alcuni per un breve periodo, mentre per altri il miglioramento era permanente.
La teoria della induzione dell’ipotermia. Raffreddare il corpo trovò scarso impiego, ma fu una delle terapie tentate anche in istituzioni prestigiose (Massachusetts Ge neral Hospital). Nel 1941 J.H. Talbott e K.J. Tillotson descrissero gli “effetti del freddo sulle malattie mentali”. I pazienti sedati venivano posti in una coperta Therm-O-Rite, tessuto simile a quello delle mummie egizie, dove circolava un liquido refrigerante. La temperatura corporea si riduceva drasticamente. In un esperimento un paziente morì per insufficienza circolatoria, ma i ricercatori riferiva- no risultati promettenti…
La teoria dell’infezione focale. Per Herry A. Cotton, direttore sanitario del New Jer- sey Hospital, le tossine batteriche dalle sedi di infezione nell’organismo venivano trasportate all’encefalo dove inducevano i disturbi mentali. Iniziò a trattare pazienti psichiatrici con interventi chirurgici per rimuovere la fonte di infezione e proseguì con grande entusiasmo per vari anni. Malgrado le notevoli polemiche, convinse altri ad adottare le sue radicali tecniche. Era un “progressista”: per lui la convinzione più dannosa della psichiatria era pensare che le psicosi fossero ereditarie. Ciò rendeva pessimisti i terapeuti. L’ereditarietà può avere qualche influenza ma non le va riserva- ta una posizione privilegiata. Era essenziale localizzare i focolai di infezione respon- sabili delle alterazioni cerebrali. Ricordava di aver lavorato in passato con Alzheimer e sosteneva che i pazienti psicotici senza eccezioni avevano tutti infezioni dentarie… Da qui la decisione “terapeutica” di togliere i denti a tutti!
Alla fine di questo excursus, necessariamente, sommario dei tentativi messi in atto per “curare” quelle che Maurice Partridge nel 1950 chiamava “malattie bizzarre”4 non possiamo non chiederci: ma perché gli psichiatri fanno ancora gli ESK? E perché si sono resi responsabili di cure (malario-terapia, insulino-terapia, loboto- mia, asportazione di ghiandole, organi e apparati ecc.) non umane, a volte fran- camente assurde? Sono “cattivi”? O che altro? Qualcuno sarà pure un po’ sadico, ma il dato non è statisticamente significativo. Per noi non sono cattivi o buoni: piuttosto dovrebbero riflettere perché non si accorgono che le loro cure diventano spesso invasive e “disperate” come avvenuto in campi analoghi ma pur sempre di assistenza alla persona: anni fa ci fu chi teorizzò e usò (“a fin di bene” per ca- rità!) catene, quelle fisiche, per i tossicodipendenti per impedire loro di fare uso di sostanze. Eppure la psichiatria alla fine del Settecento era partita con buone intenzioni: Pinel, “ubriaco” dei lumi della Ragione (tutto sembrava possibile, è l’illuminismo, è il tempo di Jean Itard e dell’enfant sauvage de l’Aveyron), libera i matti dalle prigioni. Ma li affida ad altre catene (vedi i manicomi prossimi venturi e le loro pratiche), di una violenza più sottile e mistificata, quella della scienza psichiatrica che, coeva al manicomio, emetteva i primi vagiti come teoria e si costruiva nella prassi, solido appareil de force. Dirà Foucault che, per come è la scienza delle malattie mentali, nei luoghi dove si recita il dramma della follia, non ci sarà possibilità di dialogo.
La storia della psichiatria moderna non è affatto una marcia omogenea verso il progresso, il benessere e il rispetto umano nel nome della carità, della scienza e della ragione. La psi-chiatria è la storia della sostanziale impotenza dell’uomo di fronte alla follia, è quindi anche storia di illusioni e frustrazioni, di problemi e disperazioni di studiosi, di dubbi, di falsi entusiasmi e di una serie di distorsioni di prospettive e di giudizio in cui gli stessi psichiatri son rimasti non di rado irretiti. Talora e anzi forse con una preoccupante frequenza è stata anche, purtroppo, storia di bassezze e crudeltà (Presentazione di G. Jervis a Valenstein, 1986).
Bisognerà aspettare Franco Basaglia e Psichiatria Democratica perché i matti riac- quistino dignità e rispetto. «Non siamo più oggetto in mano altrui», diceva Pasqua- le Spadi, maestro elementare e uomo di cultura, ammalatosi a un passo dalla laurea, 40 anni di manicomio ad Arezzo, presidente dell’Assemblea generale dell’Ospedale psichiatrico, vero genius loci e parlamento dell’istituzione e della sua vita quotidia- na, trasformata e democratizzata in una faticosa ma esaltante impresa collettiva. «E loro dissero e decisero» era l’incipit di ogni verbale di Assemblea, redatto dagli stessi pazienti. Lì, lavorando fianco a fianco con loro, di nuovo protagonisti delle loro vite, con la guida di Agostino Pirella e Vieri Marzi, si formò un’intera generazione, anche chi scrive, di psichiatri democratici e basagliani. Furono anni di trasforma- zione e liberazione fino alla legge che abolì i manicomi, risultato che nessuna cura tradizionalmente intesa avrebbe potuto raggiungere se a tutto l’impegno anche terapeutico profuso non si fosse affiancata la restituzione di diritti e dignità a chi viveva da decenni in condizioni subumane di promiscuità, disagio permanente e pudore violato.
BIBLIOGRAFIA
AA.VV. (2014), Le parole che sono importanti. Piccolo vocabolario della solidarietà, Feltri- nelli, Milano 2014.
Attenasio L. (a cura di) (2000), Fuori norma. La diversità come valore e sapere, Armando, Roma.
Conolly J. (1976), Trattamento del malato di mente senza metodi costrittivi, Prefazione di A. Pirella, Einaudi, Torino.
De Leonardis O. (1990), Il terzo escluso, Feltrinelli, Milano.
Donghi P., Preta L. (a cura di) (1995), In principio era la cura, Laterza, Roma-Bari. Fabbri P. (1995), Abbozzi per una finzione della cura, in Donghi, Preta (1995), pp. Fantini B. (1995), La medicina scientifica e le trasformazioni nelle teorie e nelle pratiche della medicina occidentale, in Donghi, Preta (1995), pp.
Floris M. N. (2000-2001), Le terapie disperate in psichiatria. Una valutazione storica, tesi di laurea, relatore prof. A. Pirella, Università degli studi di Torino, Facoltà di psicologia. Gardini N. (2014), s.v. Cura in AA.VV. (2014).
Marinelli A. (2002), Etica della cura e progetto, Liguori, Napoli.
Ongaro Basaglia F. (1979), s.v. Cura, in Enciclopedia Einaudi, 6, Einaudi, Torino.
Valenstein E. S. (1993), Cure disperate, Giunti, Firenze.